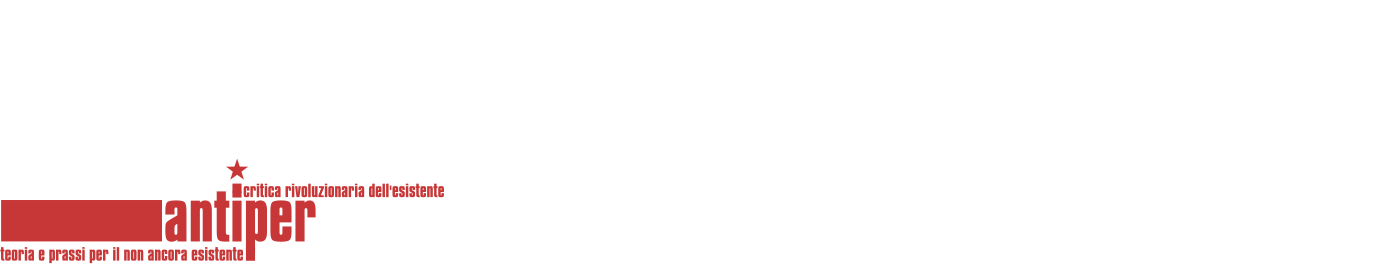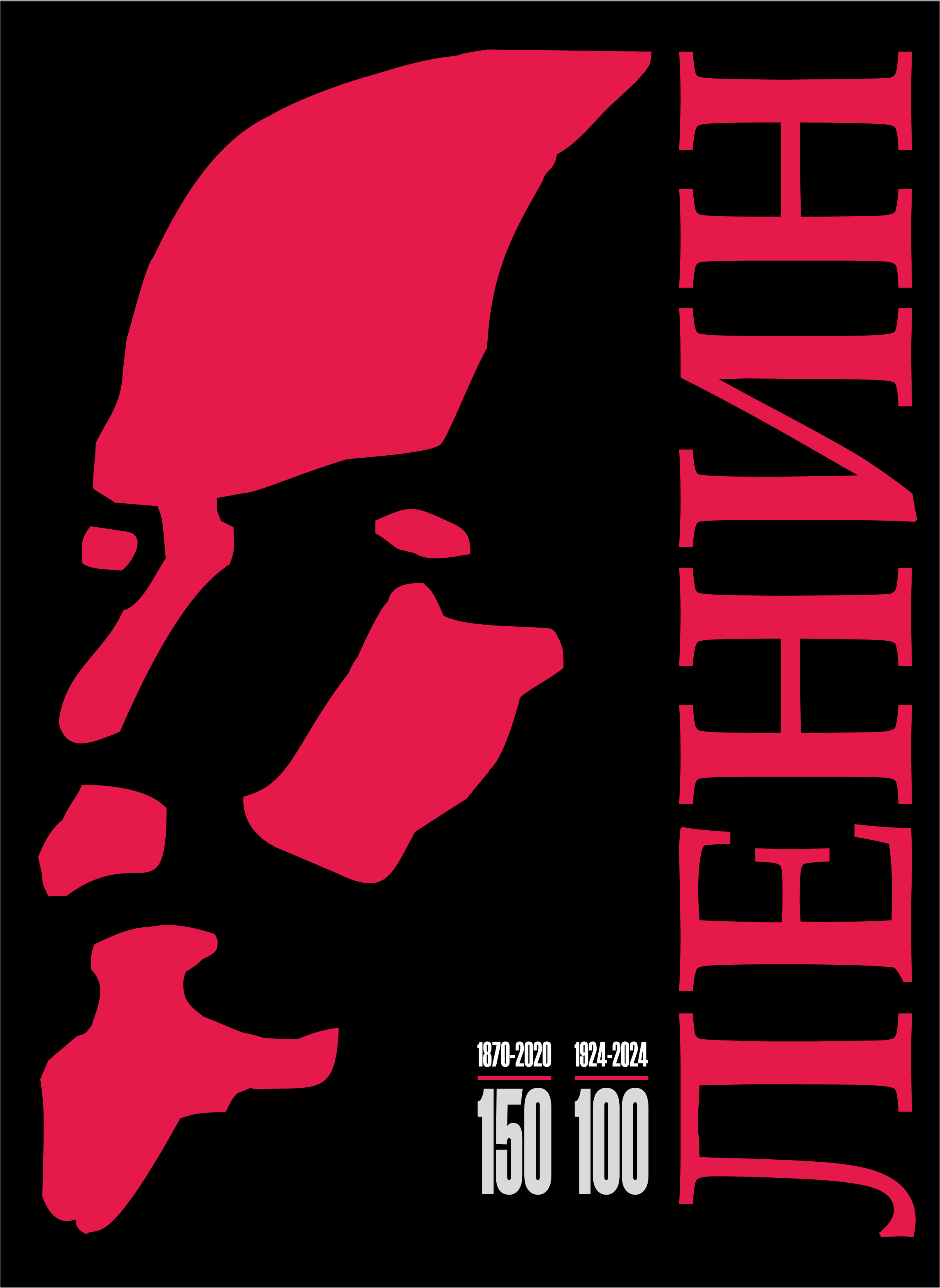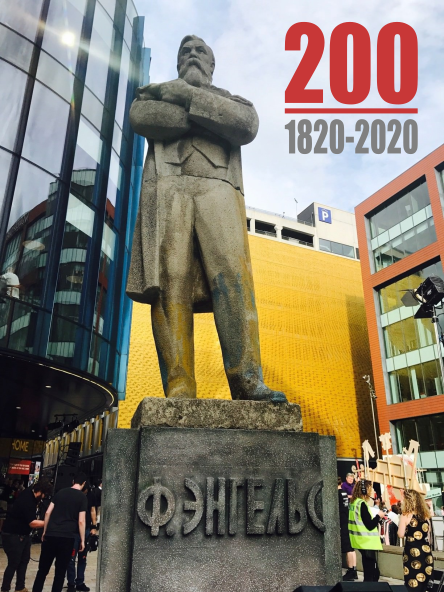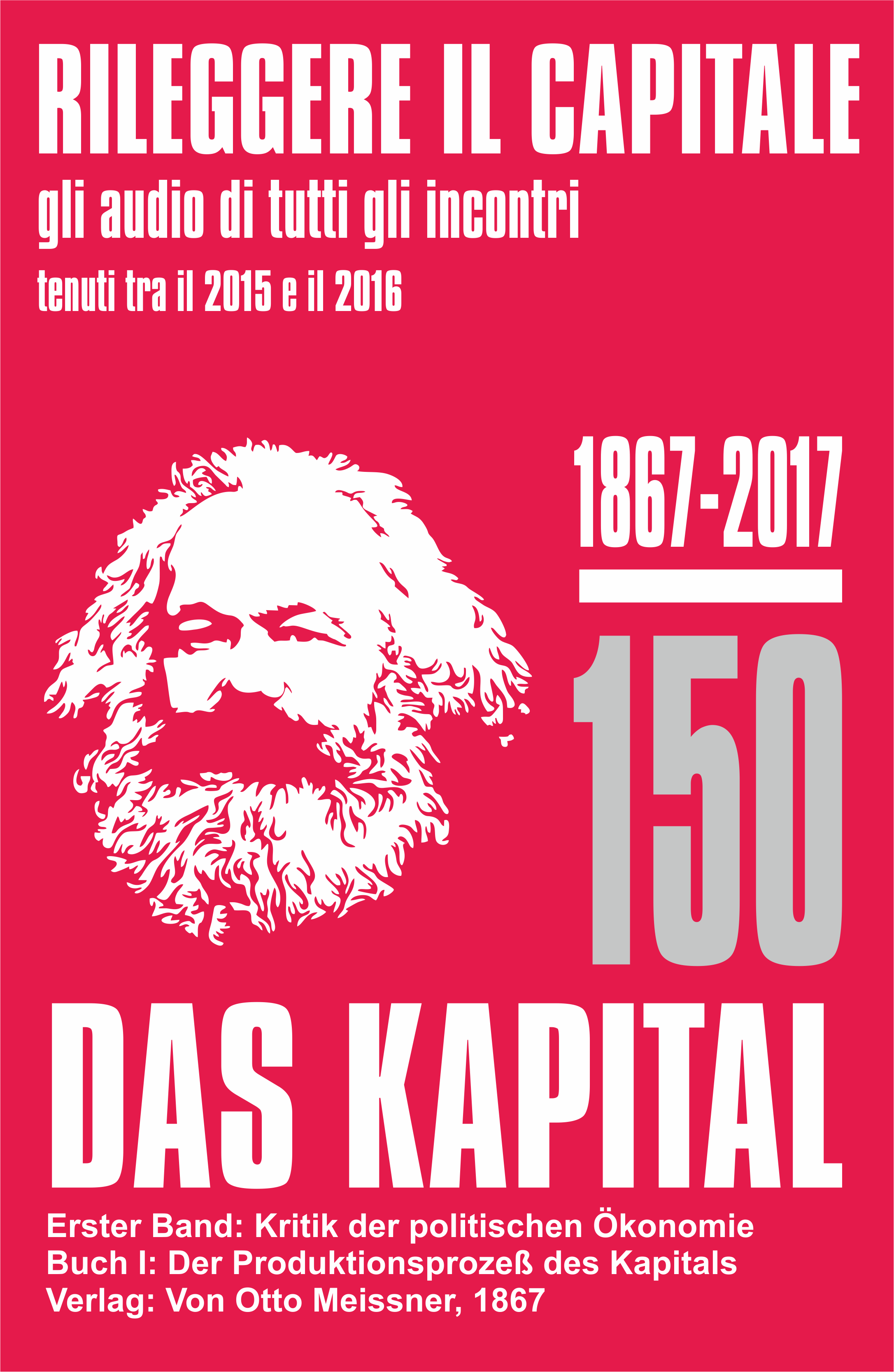Giulia Iacometti | Dualismo cartesiano?
Il punto su cui le due impostazioni appaiono più distanti sembra essere quello del rapporto tra società e natura. Si tratta di una netta separazione ontologica (ciò che Jason Moore chiama “dualismo cartesiano”) oppure di una contraddizione dialettica all’interno di una sostanziale unità?