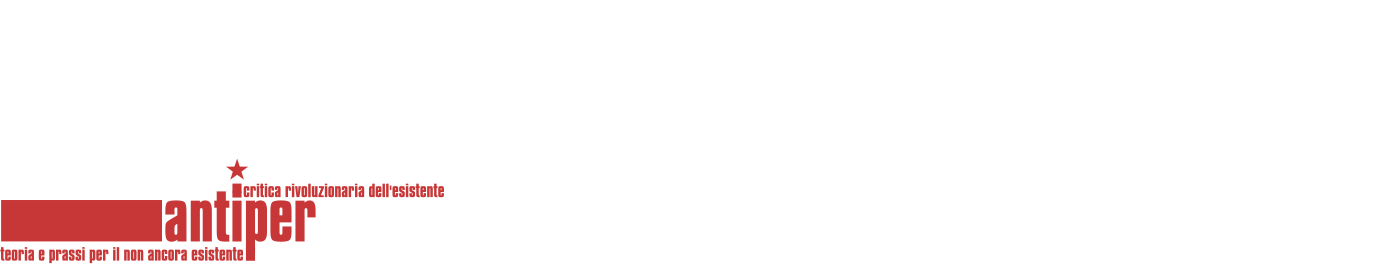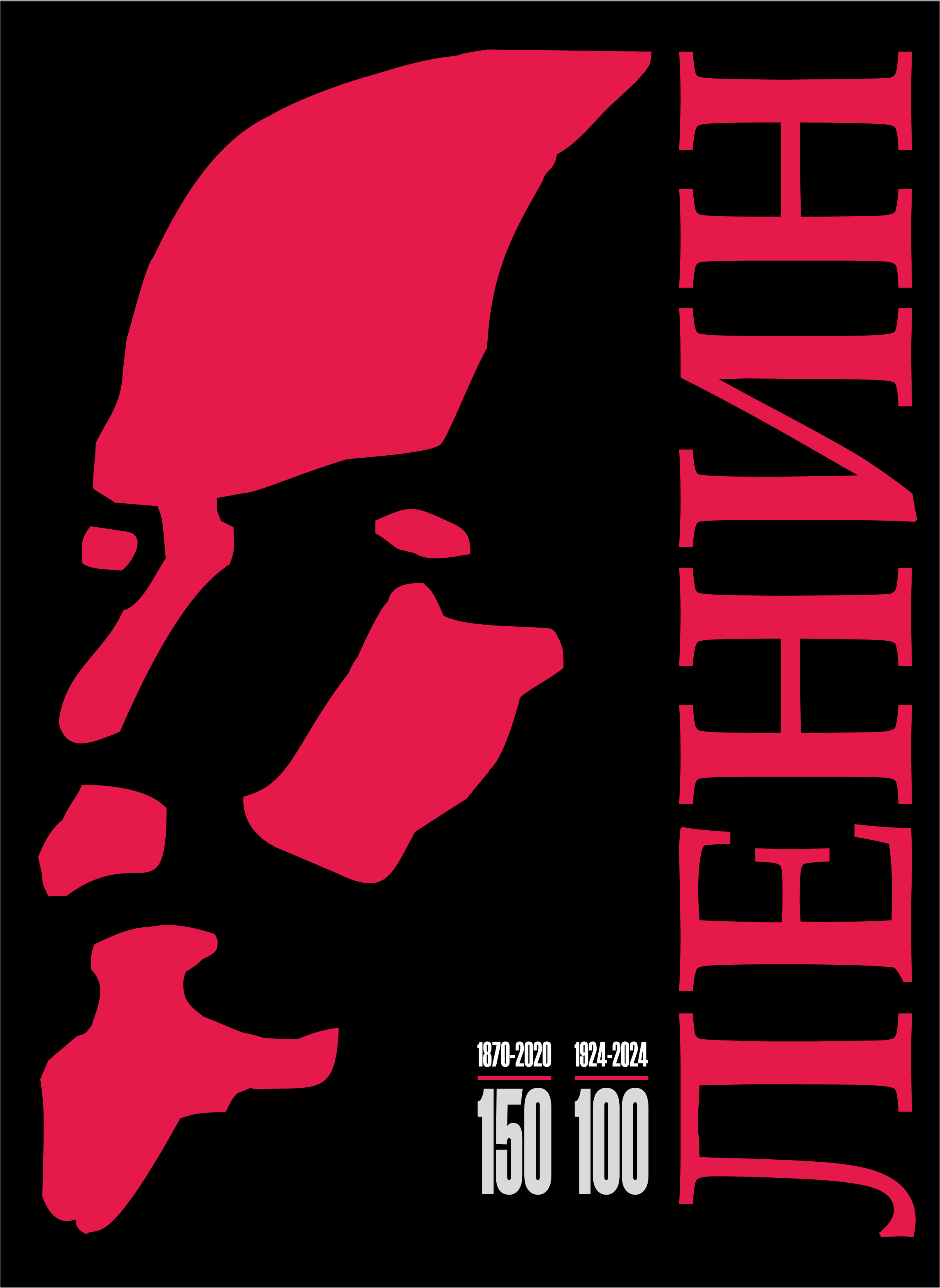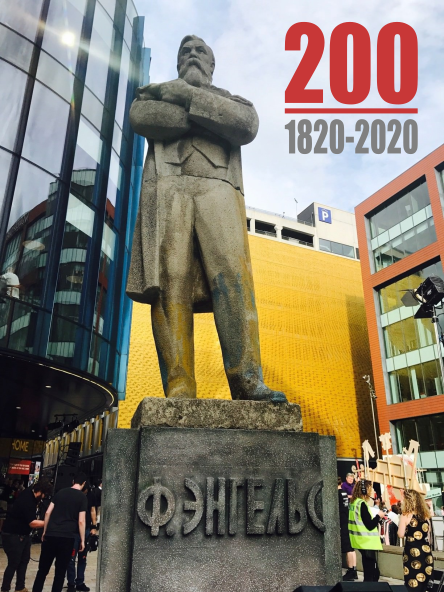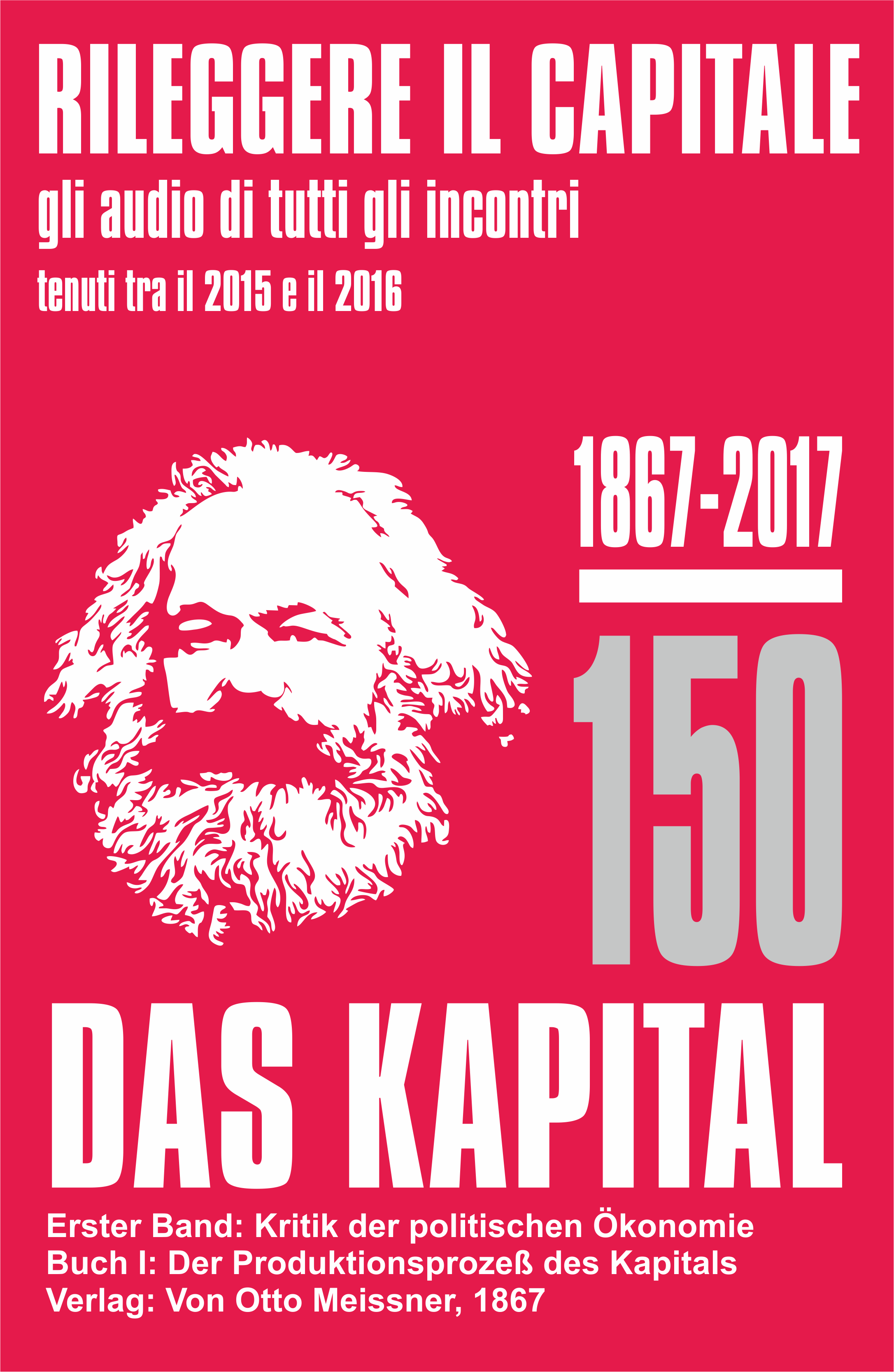L’articolo è incentrato sull’antropologia marxiana, a partire dall’idea secondo cui l’uomo è uno zoon politikon. In particolare, nella Einleitung del 1857, si afferma proprio che l’uomo è uno zoon politikon, e nel primo libro del Capitale, si ribadisce tale concetto, sottolineando il fatto che l’espressione indicata può essere tradotta con “animale sociale”, più che con “animale politico”. Più avanti ritornerò su tali passi, mostrando il fatto che non possono venire interpretati a partire dalla convinzione di un presunto “aristotelismo” di Marx: l’elemento dello zoon politikon viene completamente “trasvalutato” rispetto ad Aristotele. Questo rilievo sull’uomo come zoon politikon fa emergere la dimensione antropologica del pensiero marxiano. Metterò in luce il carattere non astratto, non essenzialistico di tale antropologia, che si radica in una situazione determinata, all’interno di un determinato contesto storico e sociale. D’altronde, proprio dal momento che lo zoon politikon viene inteso come animale sociale, più che come animale politico, il riferimento alla società risulta decisivo: cruciale si rivela quindi la questione del rapporto fra individuo e società, e anche fra individuo e comunità, e individuo e associazione. Così il percorso svolto attraverserà i concetti di società, comunità e associazione, che devono venire tra di loro differenziati, ma nello stesso tempo presentano vari tratti comuni. Vista l’enorme vastità del tema di per sé, e nello specifico in Marx, pur fornendo un approccio complessivo al problema, mi soffermerò in particolare sul lemma società in senso stretto, Gesellschaft, cercando di farne emergere gli aspetti più rilevanti. Metterò in luce il nesso fra il concetto di società, Gesellschaft e quello di comunità e “essere comune”, Gemeinschaft e Gemeinwesen, insistendo sul rapporto sociale come centrale per l’interpretazione del problema. Inoltre verrà esaminato, anche se in modo meno approfondito (essendo anche meno frequente nell’itinerario marxiano), l’elemento dell’associazione, dell’unione, Assoziation e Verein, significativo in particolare per connotare il comunismo in quanto cooperazione di uomini liberi. Nella prima parte mi soffermerò sui primi testi marxiani, e soprattutto sull’Ideologia tedesca, nella seconda parte, più ampia, esaminerò in particolare la Einleitung del ’57 e i Grundrisse, ma farò anche qualche riferimento al Capitale. Non intendo in alcun modo approdare alla delineazione di due Marx, il giovane Marx, umanista e ideologico, e il Marx maturo, scientifico. Su questo punto la tesi althusseriana, in particolare contenuta in un testo comunque importante come Per Marx [1], della “rottura epistemologica”, irrigidisce in modo non condivisibile il discorso. Invece indagherò il percorso marxiano nella sua sostanziale unitarietà, pur all’interno di una serie di problematizzazioni, e talvolta anche fratture e scarti interni. La presente trattazione è incardinata sulla critica marxiana alla società, in quanto società borghese, più che sulla questione dell’associazione comunista, anche se emergeranno alcune linee di tendenza in tal senso, in particolare in relazione al fatto che la direzione qui intrapresa è volta non all’ipostatizzazione della società a scapito degli individui, ma al contrario alla realizzazione delle singolarità operaie [2].
Mi piace:
Mi piace Caricamento...