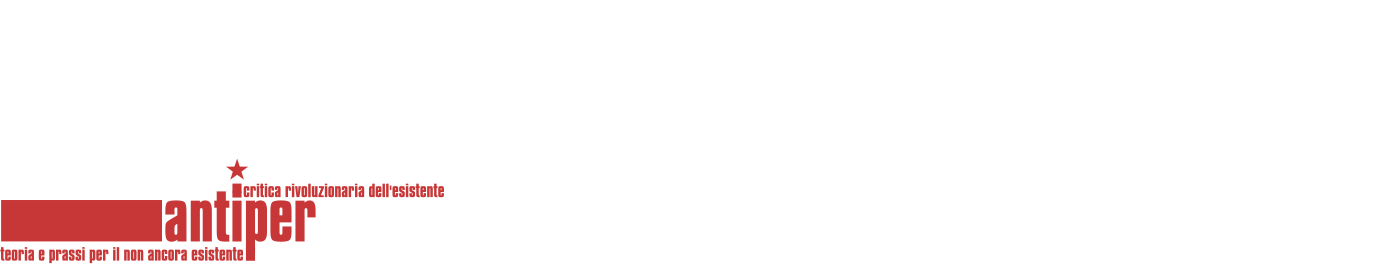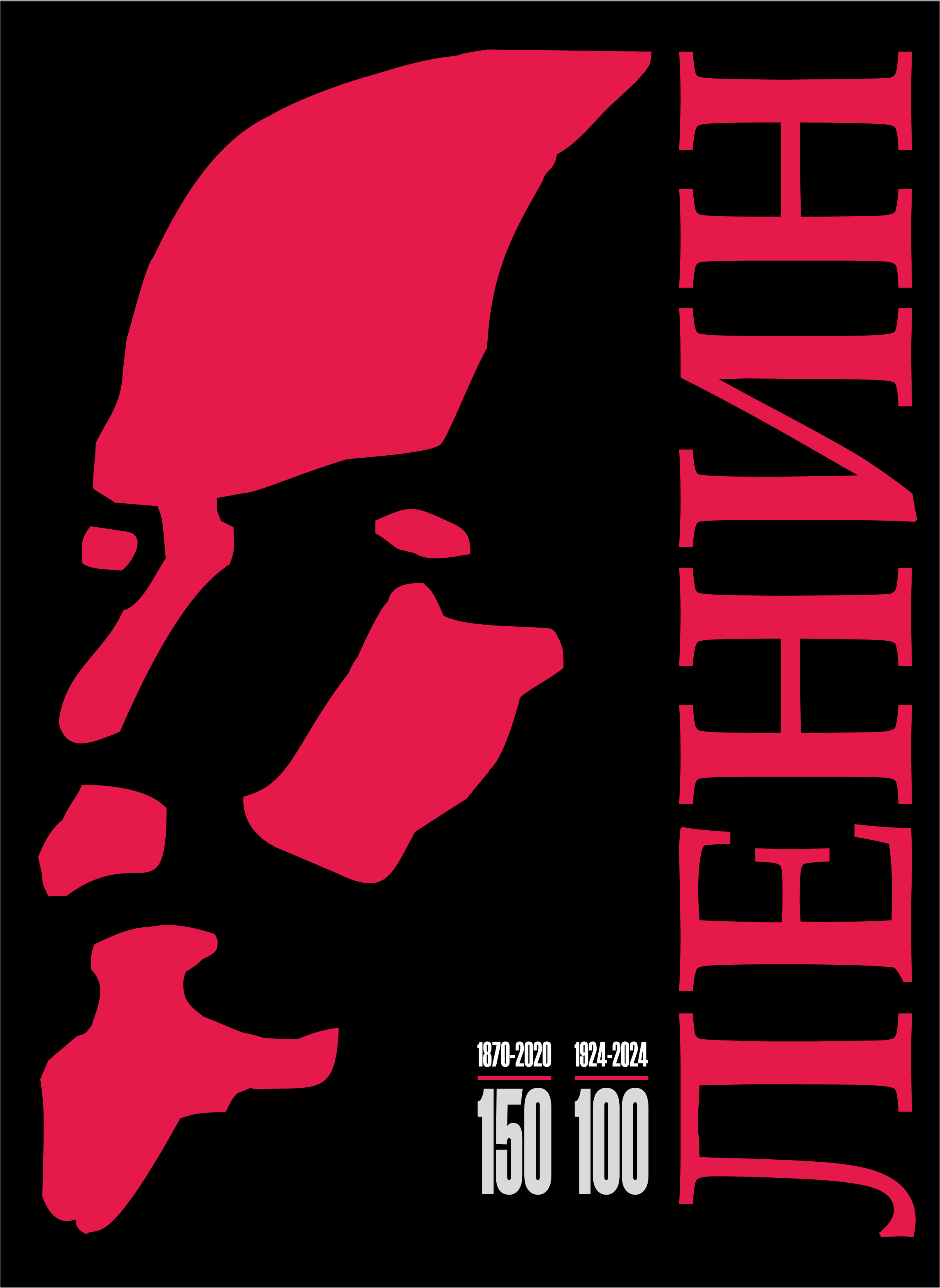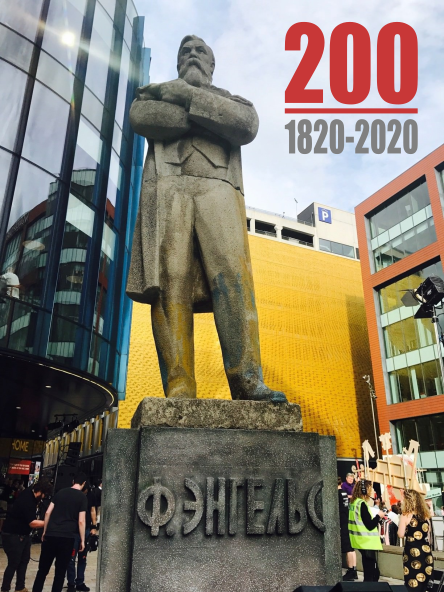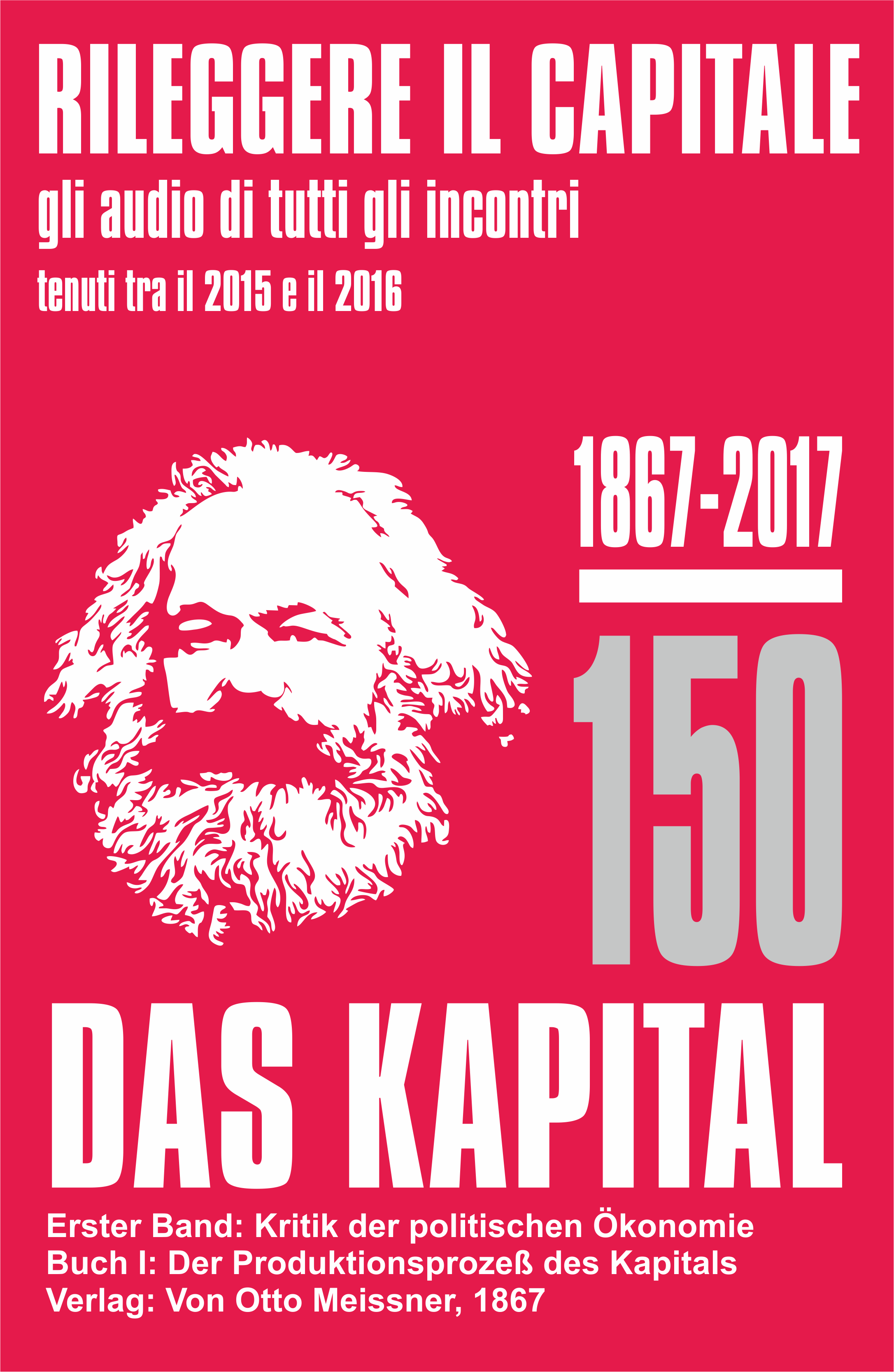Antiper | Il riarmo come veicolo di sviluppo industriale e tecnologico nell’Unione Europea

Il 18 marzo scorso Mario Draghi è stato ascoltato dalle Commissioni di Camera e Senato a proposito del suo Rapporto sulla competitività europea [1] presentato nel settembre del 2024.
Dopo il preambolo ormai d’obbligo sui rischi per la sicurezza in Europa, Draghi ha spiegato l’importanza dell’investimento nella difesa comune (anche alla luce delle recenti proposte della Commissione [2]) non tanto come una necessità legata alle preoccupazioni per l’imminente calata degli Unni, quanto piuttosto come una necessità legata al tentativo di rianimare lo sviluppo industriale e tecnologico europeo in una fase caratterizzata dal protezionismo degli USA i quali, contestualmente, conducono politiche molto aggressive di attrazione di investimenti in un’ottica di re-shoring e di re-industrializzazione. Draghi ha anzi fatto capire piuttosto chiaramente che quella dell’invasione russa è in realtà solo una scusa
«L’Europa avrebbe dovuto comunque affrontare, comunque combattere la stagnazione della sua economia e assumere maggiori responsabilità per la propria difesa in presenza di un minore impegno americano da tempo annunciato» [3]
È chiarissima, ad esempio, la preoccupazione per il ritardo tecnologico europeo in un ambito sempre più rilevante come quello dell’Intelligenza Artificiale.
«In quest’area il rapporto prende atto che il ritardo europeo è probabilmente incolmabile, ma suggerisce che l’industria, i servizi e le infrastrutture sviluppino l’impiego dell’intelligenza artificiale nei loro rispettivi settori» [4]
Proprio la guerra in Ucraina ha mostrato la sempre maggiore rilevanza dei sistemi ad alta tecnologia (telecomunicazioni, jamming, sistemi di intercettazione, sistemi di puntamento satellitare degli obbiettivi, UAV, missili ipersonici…)
«È quindi necessario dotarsi di una strategia continentale per il cloud, il super calcolo, l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza» [5]
Secondo Draghi l’investimento nell’industria militare può avere successo solo se le azioni dei vari paesi saranno coordinate e concentrate su un numero limitato di piattaforme; in questo modo si potrà superare parzialmente la storica dipendenza dalla produzione bellica americana e confidare anche in un ritorno economico dell’investimento. Il fatto è che il riarmo non è necessariamente volto alla guerra contro la Russia in nome della superiore cultura della nazista estone Kaja Kallas e dell’anziano signore imbruttito Roberto Vecchioni [6] ma anche, e forse soprattutto, dalla più prosaica intenzione di lucrare sulla guerra, più che di farla. Come infatti si è visto proprio in Ucraina non basta avere qualsivoglia tipo di armi per vincere una guerra; bisogna anche essere disposti a far macellare centinaia di migliaia di giovani. E le nostre belle “generazioni Erasmus” – in questo ha ragione l’altro intellettuale con l’elmetto Antonio Scurati – di certo non hanno lo spirito guerriero (alias la fame) che serve per ingaggiare una lotta all’ultimo sangue con un paese che, volenti o nolenti, negli ultimi due secoli ha messo in riga Napoleone, Alessandro II, Hitler e la NATO.
Il ritorno dell’equilibrio di potenza nelle relazioni internazionali e la sostanziale marginalizzazione dell’azione diplomatica spingono tutti a dotarsi della maggiore forza possibile. Nessuno è al sicuro dall’aggressività dell’imperialismo in crisi nord-americano e dei suoi alleati; se l’Iran non avesse sviluppato un proprio programma nucleare e un sistema di alleanze internazionali (Russia, Cina e BRICS in generale) avrebbe probabilmente giù fatto la fine dell’Iraq. La Siria e il Libano, che non avevano questa forza, sono state spianate dall’aggressione congiunta (anche se non necessariamente coordinata) di Turchia, Israele, USA e ancelle arabe varie.
Il documento di briefing presentato da Draghi ricorda che anche nel Piano Letta [7] era prevista una sempre maggiore centralizzazione a livello comunitario delle questioni legate alla difesa militare
«Ciò premesso, il rapporto indica 4 settori principali da collocare al centro del mercato unico nei prossimi anni; nell’analisi di Letta, essi rappresentano asset strategici europei e sui quali in futuro dovrebbe prevalere la dimensione unionale su quella nazionale. Si tratta dei settori seguenti: 1) difesa: non rientra nelle competenze dell’UE, ma sta assumendo un’importanza strategica crescente, anche nel settore industriale» [8]
Perché il polo imperialista europeo, in grandissima difficoltà su tutti i versanti, abbia scelto quello delle armi come terreno sul quale tentare la propria risalita competitiva è spiegabile, almeno in parte, con il fatto che storicamente l’industria delle armi è stata trainante dal punto di vista industriale e tecnologico. La rete Internet stessa, ad esempio, deriva da un progetto di rete militare (ARPAnet). E con i venti di guerra che soffiano attualmente nel mondo è chiaro che quello delle armi è un business destinato ad avere mercati sempre più sconfinati.
Del resto, gli USA stessi riuscirono ad uscire dal buco in cui erano sprofondati dopo il crack di Wall Street del 1929 solo attraverso le enormi commesse militari [9] e non certo con le politiche del cosiddetto New Deal. Il problema è che, alla fine, la sovrapproduzione di armi può essere smaltita solo usando tali armi: direttamente oppure indirettamente, vendendole a chi le usa.
Dolori, in ogni caso, per il genere umano.
Note
[1] The Draghi report on EU competitiveness.
[2] Gli 800 miliardi di investimenti, per intenderci.
[3] Audizione di Mario Draghi in Senato del 18 marzo 2025.
[4] Audizione.
[5] Audizione.
[6] Strano che dal palco della manifestazione del 15 marzo 2025 Vecchioni non abbia citato Kant tra i “nostri” (come avrebbe fatto il capo del battaglione Azov).
[7] Enrico Letta, Much more than a market. Speed, security, solidarity empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens, April 2024
[8] Mario Draghi, Il rapporto sul futuro della competitività europea, Documentazione per le Commissioni. Attività dell’Unione Europea, n.33, 26 settembre 2024.
[9] Cfr. Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Il mulino, Bologna, 2022.