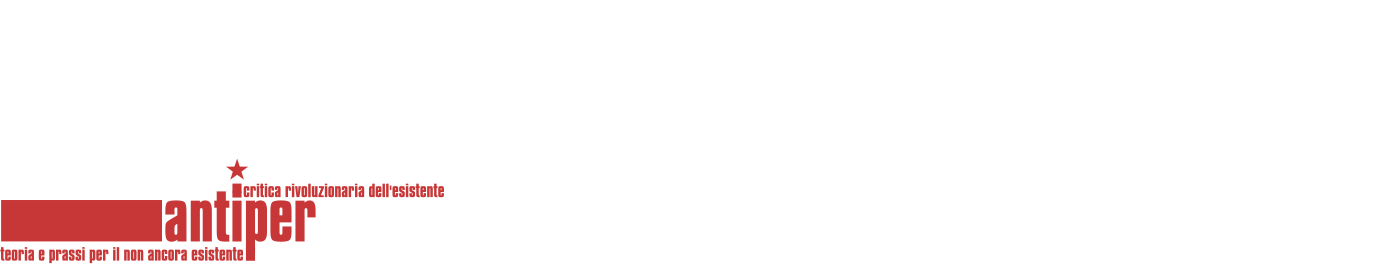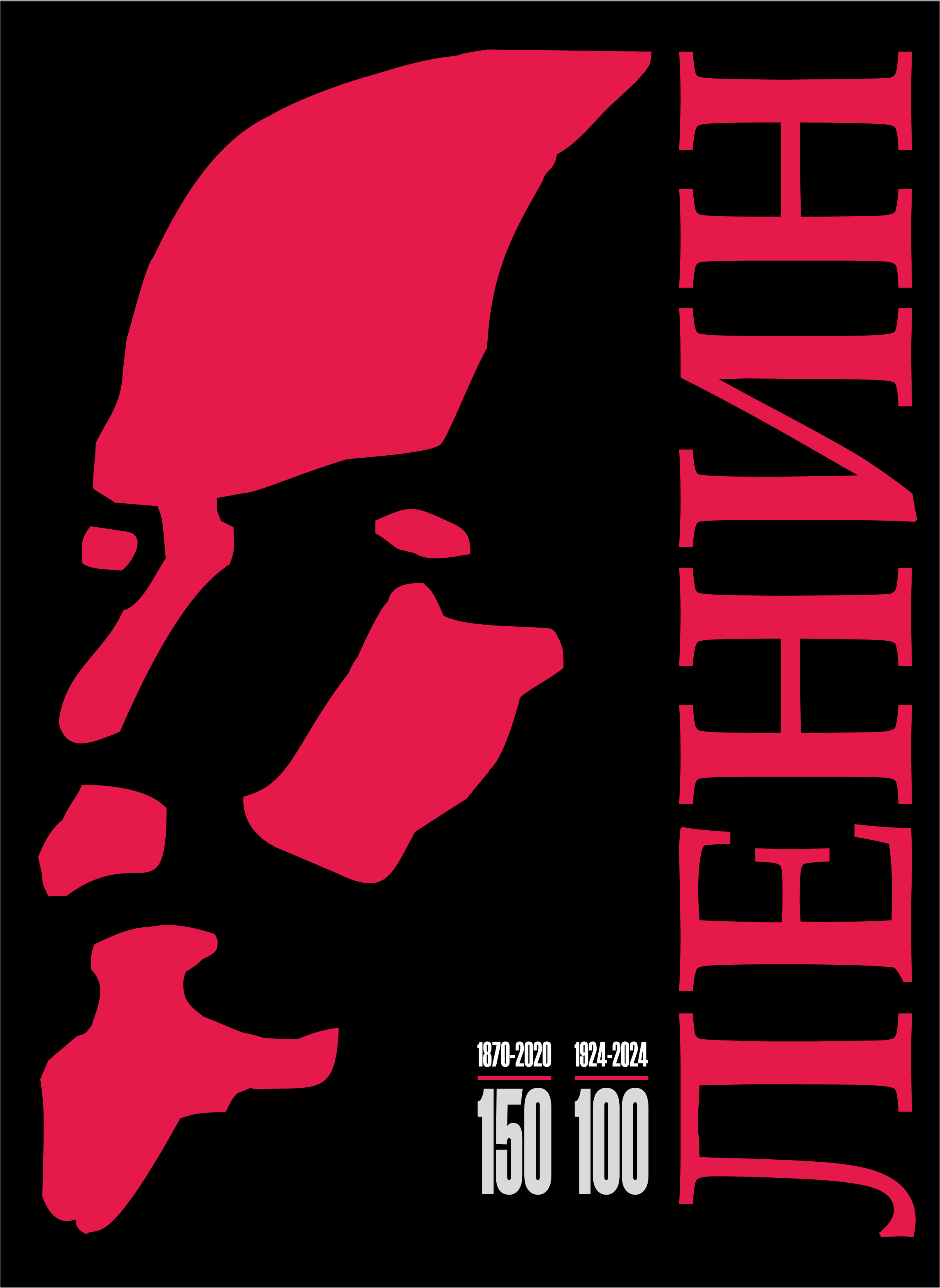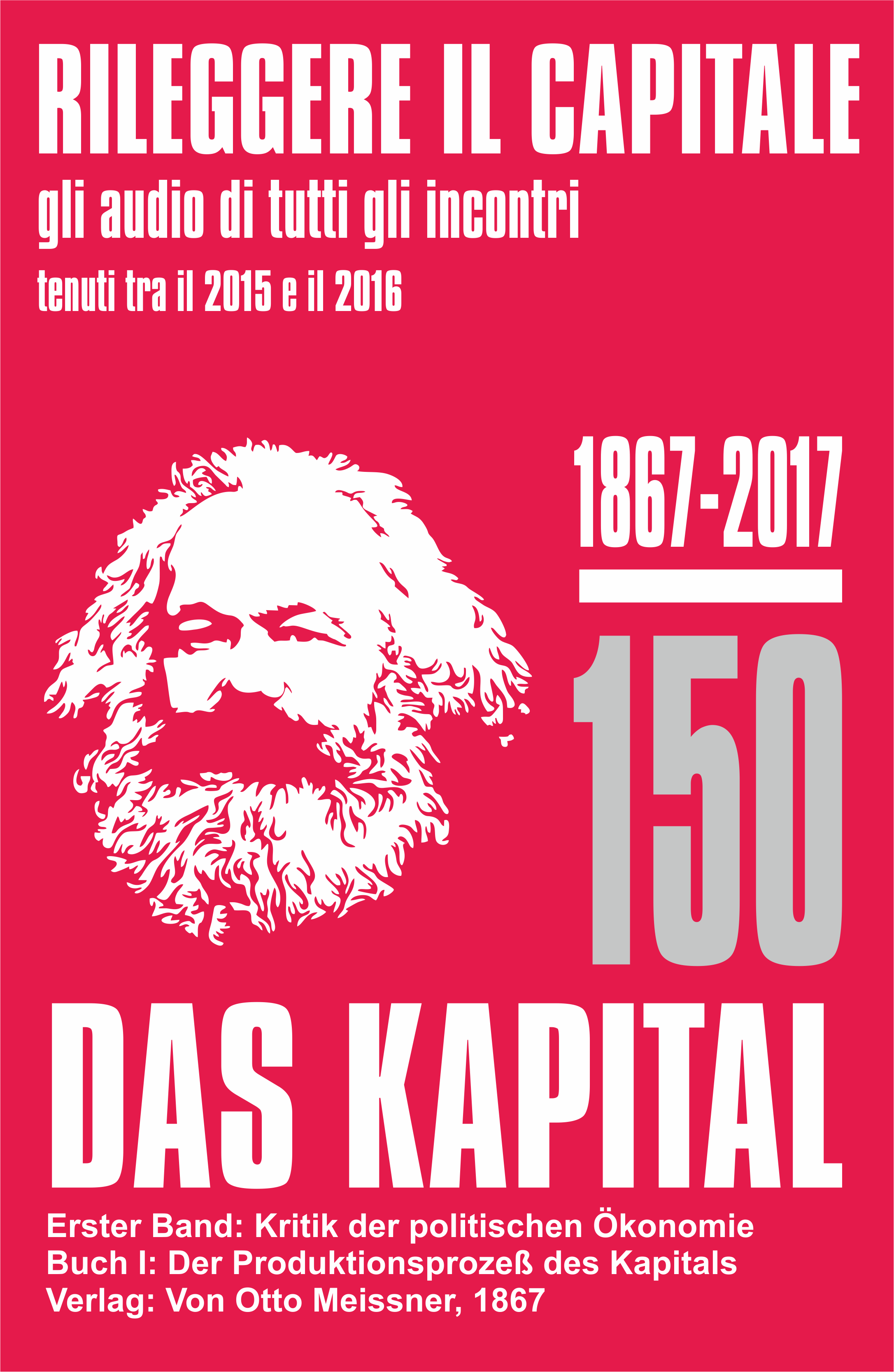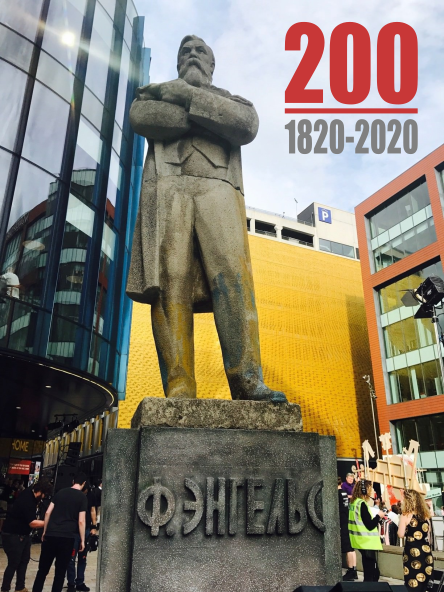Marco Riformetti | Umberto Massola e gli scioperi del marzo-aprile 1943. Tra spontaneità e organizzazione
Tratto da Marco Riformetti, Umberto Massola e gli scioperi del marzo-aprile 1943, Paper per l’esame di Storia dell’Italia Contemporanea, Storia e civiltà, Pisa, giugno 2022

Sull’importanza che i comunisti attribuiscono alla classe operaia come segmento sociale capace di guidare le masse popolari nella lotta contro il fascismo non possono esserci dubbi. Nel giugno del 1940, mentre l’Italia entra nel conflitto mondiale, è soprattutto alla classe operaia – e in particolare alla classe operaia del nord – che i comunisti fanno appello
«Esiste in Italia una forza capace di unire il popolo intero in un solo blocco solido e compatto, di condurlo alla lotta contro la dittatura fascista, contro la guerra imperialista, per la libertà. Questa forza è il potente esercito di quattro milioni di operai industriali, concentrati nelle grandi fabbriche di Milano, di Torino, di Genova [1], di Napoli, di Brescia e di cento altre città, è l’enorme massa degli operai agricoli, curvi sotto il giogo dei grandi proprietari terrieri. Questa è la nostra eroica classe operaia. Ciò che oggi manca alla classe operaia è la coscienza della propria potenza, è una solida organizzazione proletaria» [2]
Non è dunque un caso se è proprio la classe operaia settentrionale a dare il via alle mobilitazioni contro il fascismo e, in definitiva, a provocare l’inizio della sua catastrofe.
Il 1943 è un tornante storico
«anno in cui divenne evidente la centralità della questione operaia nella società e nella politica italiana» [3]
E questa centralità è già un fatto politico.
Al momento della Dichiarazione le organizzazioni antifasciste sono ancora costrette all’esilio mentre nel paese la rete dei contatti è tutta da ricostruire. Ed è proprio questa la missione a cui è chiamato Umberto Massola.
Nel campo degli studi resistenziali il peso dell’iniziativa clandestina del partito comunista nella preparazione e nello svolgimento degli scioperi del 1943 è stato messo in discussione da due punti di vista: un punto di vista più apertamente “revisionista” in cui il ridimensionamento del ruolo dei comunisti ha l’effetto – quando non l’obbiettivo – di sminuire la portata politica degli scioperi e di ribadire la retorica del consenso verso il regime (si pensi a storici come Renzo De Felice); c’è poi un altro punto di vista, più “spontaneista”, che ridimensiona il ruolo dell’organizzazione comunista soprattutto per enfatizzare l’azione spontanea delle masse. Ma la “spontaneità” non è solo il riflesso deterministico di condizionamenti economici bensì il riflesso di un complesso di condizionamenti che sono anche storici, politici, culturali… e che influenzano la determinazione ad agire. Detto questo, certamente le situazioni non sono tutte uguali: in molti casi c’è una chiara direzione politica dello sciopero, in altri casi lo sciopero è spinto soprattutto da “agitatori” interni alla fabbrica che agiscono in modo meno centralizzato [4].
Nota
[1] La rete genovese comincia a consolidarsi solo nel 1942, subendo anche perdite (ottobre) NdA (Cfr. MAGNANI [2010]).
[2] Dichiarazione del PCI dopo l’entrata in guerra dell’Italia, giugno 1940, in «Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale. Relazione e documenti presentati dalla direzione del partito al V Congresso del Partito comunista italiano», Editori Riuniti, Roma, 1963.
[3] GALLO [2015], pag. 106.
[4] MASSOLA [1973], pag. 9.