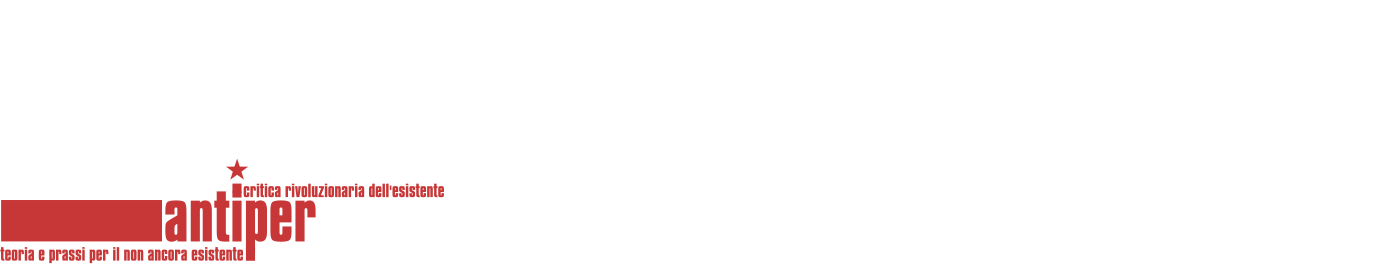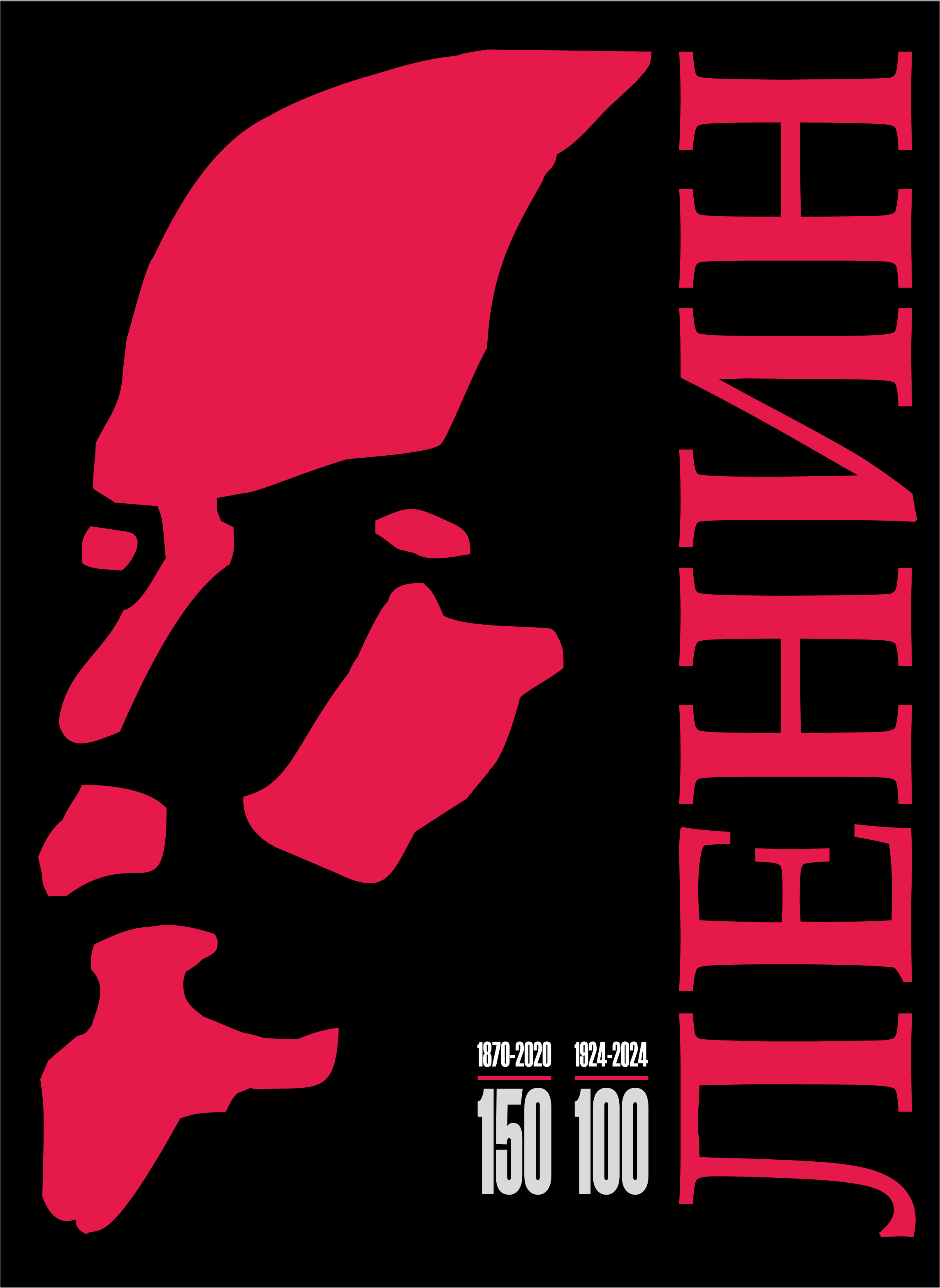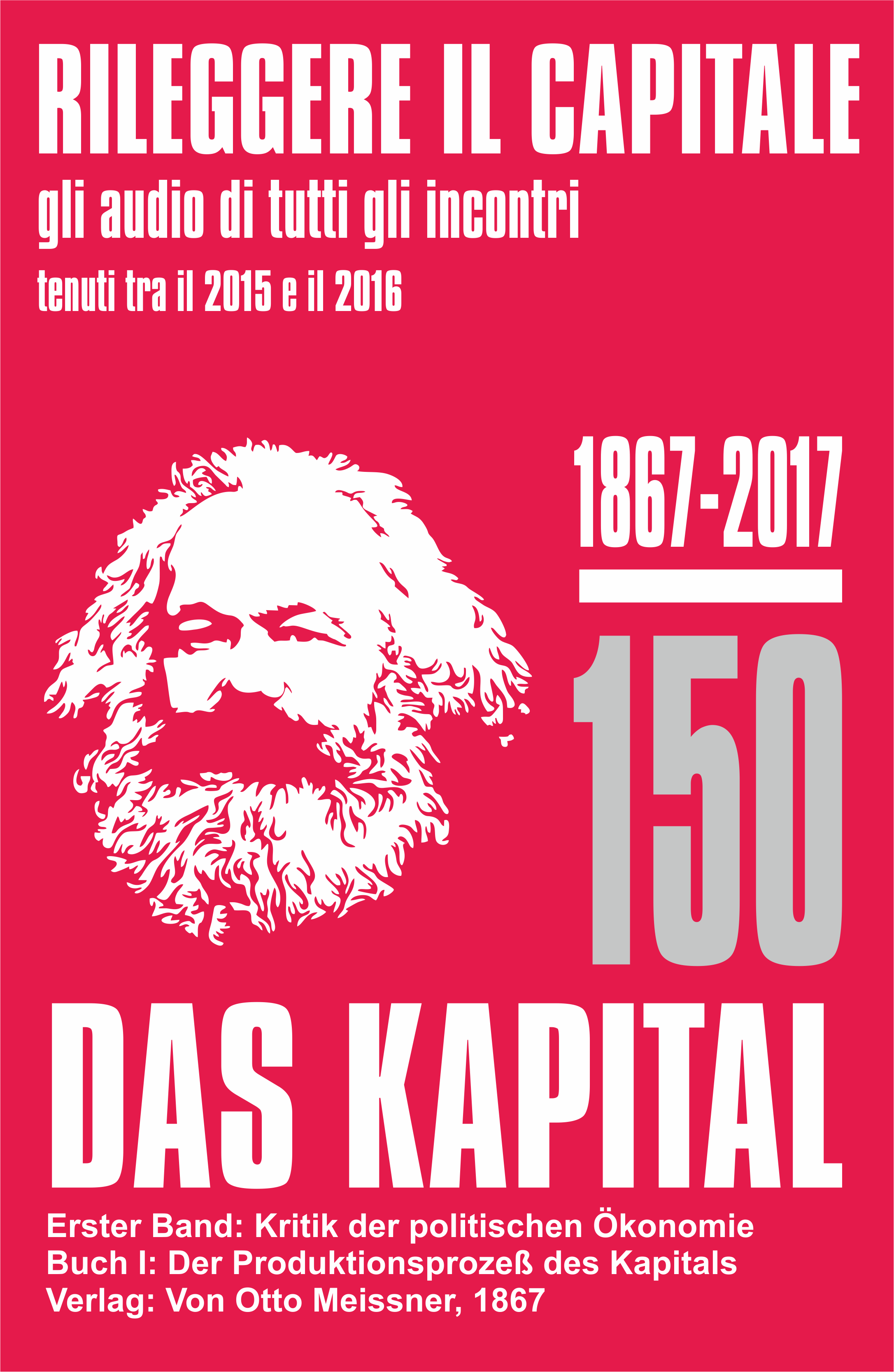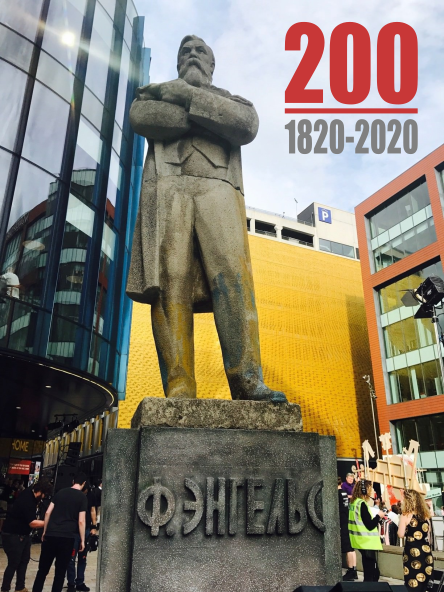Marco Riformetti | La situazione storica a Firenze nell’epoca della rivolta dei Ciompi
Prima parte del paper di Storia politica e istituzionale del Medioevo dedicato all’analisi del testo di Ernesto Screpanti L’angelo della liberazione nel tumulto dei Ciompi, Firenze, giugno-agosto 1378 (Tedaliber, Firenze, Terza edizione, 2021) | LINK (PDF su Academia)

Ernesto Screpanti propone un’operazione storiografica interessante (oggi abbastanza desueta) ovvero l’applicazione di un codice storico-epistemologico moderno di carattere marxista al periodo pre-moderno (ed anzi tardo-medievale) della seconda metà del Trecento.
É stata talvolta suggerita l’idea che l’arsenale teorico marxiano fosse consono soprattutto, se non esclusivamente, all’analisi del modo di produzione capitalistico, quindi ad un passato tutto sommato prossimo. In realtà questo non è vero ed esistono studi importanti sulle formazioni economico-sociali pre-capitalistiche realizzati tanto da Marx ed Engels quanto dalla successiva storiografia di ispirazione marxista. Solo per fare un esempio, nel capitolo XXIV del Capitale [1] Marx descrive alcuni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il processo storico di transizione dal modo di produzione feudale al modo di produzione capitalistico.
In ogni caso Screpanti dichiara esplicitamente che la Firenze del Trecento è
«una città la cui struttura economica e sociale non era più feudale, ma già pienamente capitalistica» [2]
anche se persistono residui feudali ancora molto influenti.
Come detto, la ricerca di Ernesto Screpanti è una lettura politica del tumulto caratterizzata da un chiaro approccio marxista le cui categorie riecheggiano in molti passaggi, a cominciare dall’uso del termine rivoluzione per caratterizzare l’approdo finale dell’insurrezione dei Ciompi, iniziata in modo sostanzialmente “rivendicativo” e poi evoluta verso un progetto di radicale trasformazione degli assetti politici e istituzionali.
Il quadro economico e finanziario
Alla fine del Trecento Firenze è una potenza economica, finanziaria e politica internazionale. I banchieri fiorentini gestiscono le casse di papi e re di cui finanziano persino le guerre [3]. Il fiorino è una valuta globale, probabilmente la più importante d’Europa (e dunque del mondo) in quel momento. La forza di Firenze è tale che la città finisce per diventare un sorta di centro di risoluzione delle controversie commerciali internazionali attraverso il cosiddetto Tribunale della Mercanzia.
Ma Firenze non è solo una potenza commerciale e finanziaria, bensì anche e soprattutto una potenza industriale. Da qualche decennio la qualità dei tessuti che vengono prodotti in città è aumentata costantemente e con essa la loro diffusione in tutta Europa. Al centro della produzione dei tessuti c’è la più importante corporazione fiorentina ovvero l’Arte della Lana che Screpanti definisce “un autentico stato nello stato” per via del suo potere politico oltre che economico. L’Arte della Lana è in grado di ottenere leggi a proprio favore e riesce ad imporre le proprie regole anche “manu militari” attraverso il ricorso a milizie mercenarie e ad un particolarissimo sistema giudiziario privato (riconosciuto però dal Comune, dunque tecnicamente legale) al cui centro è collocata la figura del cosiddetto Ufficiale Forestiere. Questo ufficiale si chiama “forestiere” perché viene fatto arrivare da fuori città affinché, essendo esterno alle diatribe cittadine, possa essere imparziale nelle sue decisioni, ma in realtà è solo un funzionario alle dipendenze dell’Arte della Lana che viene chiamato ad imporre con la forza la disciplina ai lavoratori i quali lo ripagano con tutto l’odio di cui sono capaci; non è un caso che l’abolizione dell’Ufficiale Forestiere venga a costituire una delle primissime rivendicazione dei Ciompi in rivolta.
È difficile valutare il numero di imprese e di addetti legati all’“industria” [4] tessile. Intanto esistono molti lavoratori interni agli opifici, ma anche molti lavoratori esterni che tessono a domicilio. Screpanti calcola 15-20 mila lavoratori per 3-400 imprese. Naturalmente i numeri sono solo indicativi e oscillano significativamente in occasione di eventi particolari: si pensi all’epidemia di peste della fine degli anni ‘40 o anche agli effetti della stessa repressione dei Ciompi dopo la rivolta, repressione che spingerà moltissimi lavoratori ad abbandonare la città.
Firenze, lo abbiamo detto, è una città molto importante dal punto di vista finanziario e quindi, come quella degli industriali (Lana), anche l’arte dei banchieri (Calimala) è molto potente; talmente potente da essere in grado di sfruttare a proprio vantaggio anche alcuni meccanismi pseudo tributari. In realtà a Firenze non esiste un vero e proprio sistema tributario e la Repubblica reperisce le risorse di cui ha bisogno soprattutto attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico, le cosiddette prestanze. Si tratta di un sistema di finanziamento pubblico che riesce nell’operazione apparentemente impossibile di far aumentare sia la ricchezza dei ricchi, sia la povertà dei poveri (in questo senso, un sistema davvero modernissimo). Senza indugiare eccessivamente sui vari meccanismi di acquisto dei titoli del debito pubblico emessi dal Comune (meccanismi che peraltro Screpanti descrive in modo approfondito essendo egli un economista) si può riassumere in questo modo: quando lo Stato (il Comune) ha bisogno di denaro se lo fa “prestare” dai cittadini garantendo in cambio un certo tasso di interesse. I cittadini più poveri in genere non sono in grado di fronteggiare la propria quota della prestanza e la rivendono ad un qualche cittadino ricco che in cambio esige un “dono”, ovvero uno sconto. In questo modo il povero invece di pagare 10 al Comune paga 1 al banchiere (e sopravvive) mentre il banchiere sborsa 9 per ottenere un credito di 10 (e si arricchisce); il denaro fluisce così dalle tasche vuote dei poveri verso quelle già piene dei ricchi.
Intorno alla prassi del “dono” sorge un vero e proprio dibattito tra intellettuali (chierici) per stabilire se tale meccanismo configuri o meno il peccato di usura, molto sentito a quei tempi.
Esiste anche una vera e propria borsa in cui i titoli vengono scambiati liberamente e dove possono essere realizzati guadagni persino superiori a quelli ricavati dalla speculazione sui titoli del debito pubblico.
Infine, quando il Comune ha acuto bisogno di denaro ricorre al meccanismo del “monte uno a tre” in cui un prestito di 100 fiorini viene registrato come da 300, con relativa triplicazione degli interessi. Anche qui, siccome sono solo i ricchi che possono prestare denaro al Comune, sono solo i ricchi che si arricchiscono con i prestiti a interesse triplicato.
Per completare il quadro economico e finanziario Screpanti propone un piccolo approfondimento sulla doppia circolazione della moneta: da una parte il fiorino, la moneta forte, anzi fortissima,che serve per le transazioni commerciali e per l’acquisto di beni di consumo di lusso; dall’altra parte il soldo [5], la moneta debole, che viene usata dai datori di lavoro per pagare i salari dei lavoratori e i servizi dei piccoli artigiani, nonché per acquistare beni di consumo popolare. Di tanto in tanto il Comune provoca la svalutazione del soldo rispetto al fiorino [6]; in questo modo la quota-salari che i Lanai – i padroni dell’Arte della Lana – pagano ai dipendenti (diretti e indiretti) e agli artigiani si riduce rispetto ai profitti, che vengono invece pagati in fiorini. Quella della rivalutazione del soldo sarà un’altra delle prime rivendicazioni dei Ciompi.
Un’analisi a sé stante merita la struttura politico-istituzionale di Firenze che, pur definendosi Repubblica, ha ben poco di democratico ed è congegnata per garantire il potere della borghesia sia nei confronti del popolo minuto e della massa dei lavoratori, sia nei confronti degli aristocratici stessi ai quali, dopo l’approvazione dei cosiddetti Ordinamenti di giustizia [7], è da lungo tempo proibita la candidatura alle magistrature pubbliche (a meno che la persona non sia iscritta ad una qualche Arte [8]).
Proprio in quanto espressione dell’ascesa politica della borghesia e del capitalismo mercantile e proto-industriale Firenze diviene un vero e proprio modello
«Verso la fine del Trecento il Comune acquisì coscienza della propria vocazione di guida del movimento di liberazione dei municipi italiani, “divenne un’articolata sostenitrice dell’ideale della città-stato, e dal 1370 emerse come il campione e il leader del governo repubblicano nella penisola» [9]
Note
[1] Karl Marx, Il capitale, Libro primo, Sezione VII, Capitolo XXIV, Sulla cosiddetta accumulazione originaria di capitale, Roma, Editori Riuniti, 1980.
[2] p. 252, ed. dig.
[3] Ogni tanto “rimettendoci la camicia” come nel caso dei Peruzzi e dei Bardi con i re d’Inghilterra.
[4] Screpanti parla della Firenze degli anni ‘70 come di una città quasi industriale; forse Marx avrebbe parlato di una città pre-manifatturiera. Ma il parallelo è comunque molto suggestivo.
[5] Questo è una parte della lira di picciolo, moneta in argento di valore molto inferiore al fiorino d’oro. Esiste anche un “soldo d’oro” (ma non è a questa moneta che ci si riferisce nel testo quando si parla di “soldo”).
[6] Se il valore del soldo rispetto al fiorino cade (svalutazione del soldo) significa per lo stesso fiorino servano ora più soldi. Pertanto, se prima il rapporto era (poniamo) 100 soldi = 10 fiorini ora il rapporto diventa 100 soldi = 8 fiorini. Chi paga in soldi essendo pagato in fiorini si avvantaggia.
[7] Introdotti alla fine del Duecento. Cfr. Guido Pampaloni, Ordinamenti di Giustizia, Treccani.
[8] Come fece lo stesso Dante Alighieri.
[9] p. 18, ed. dig.