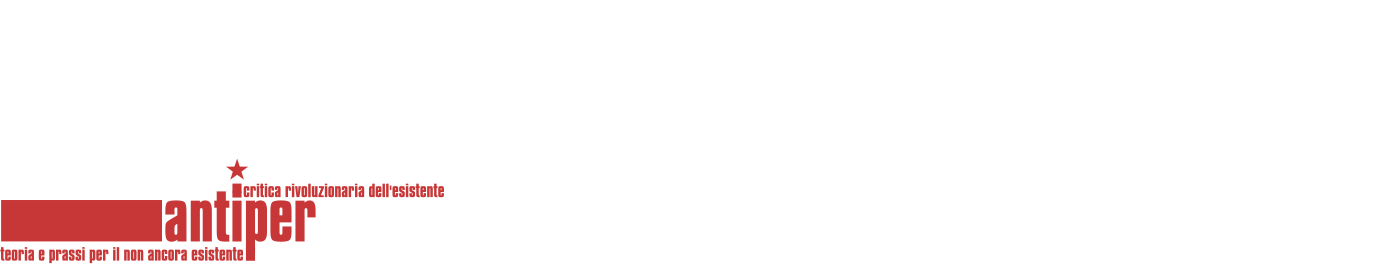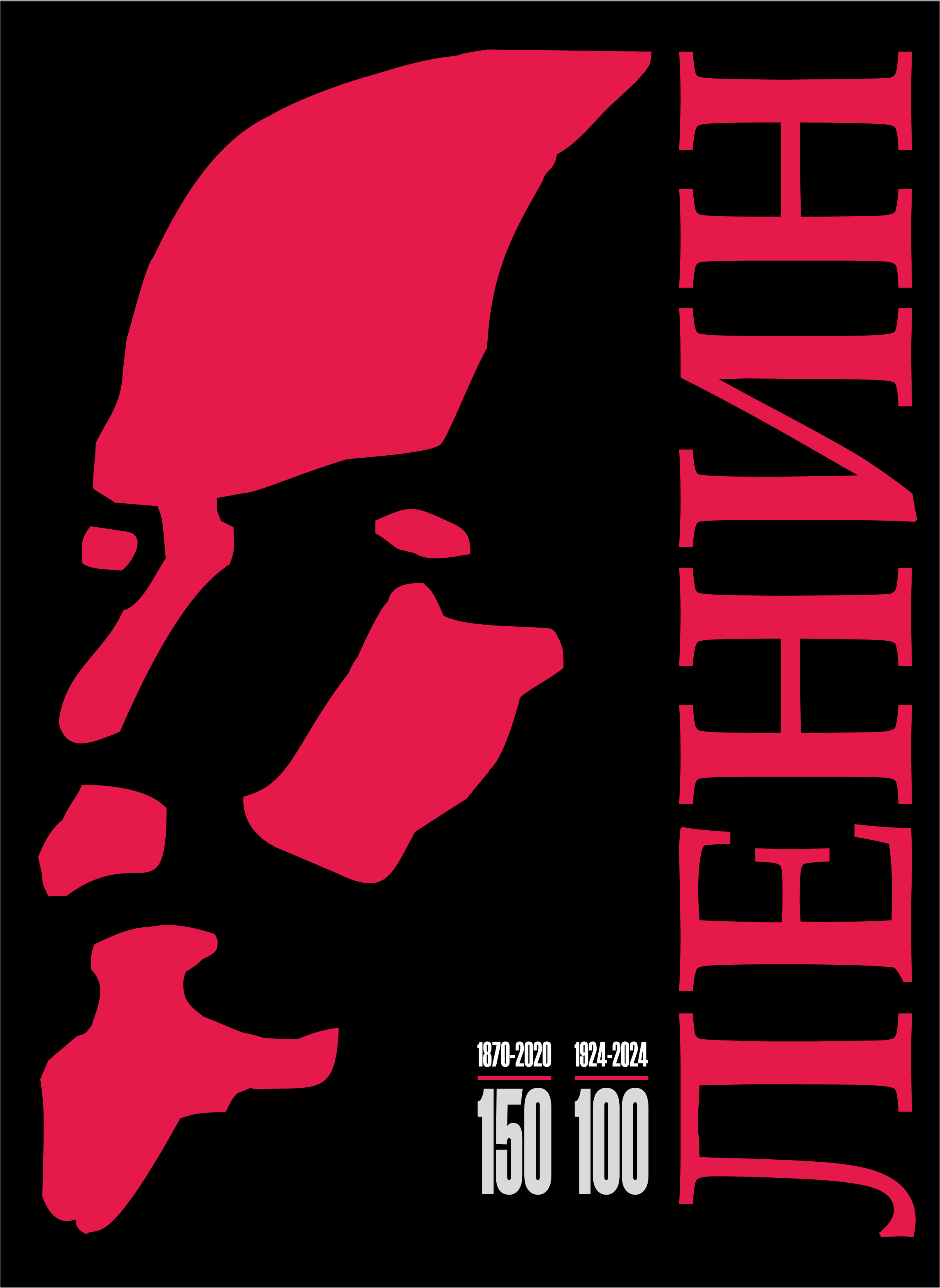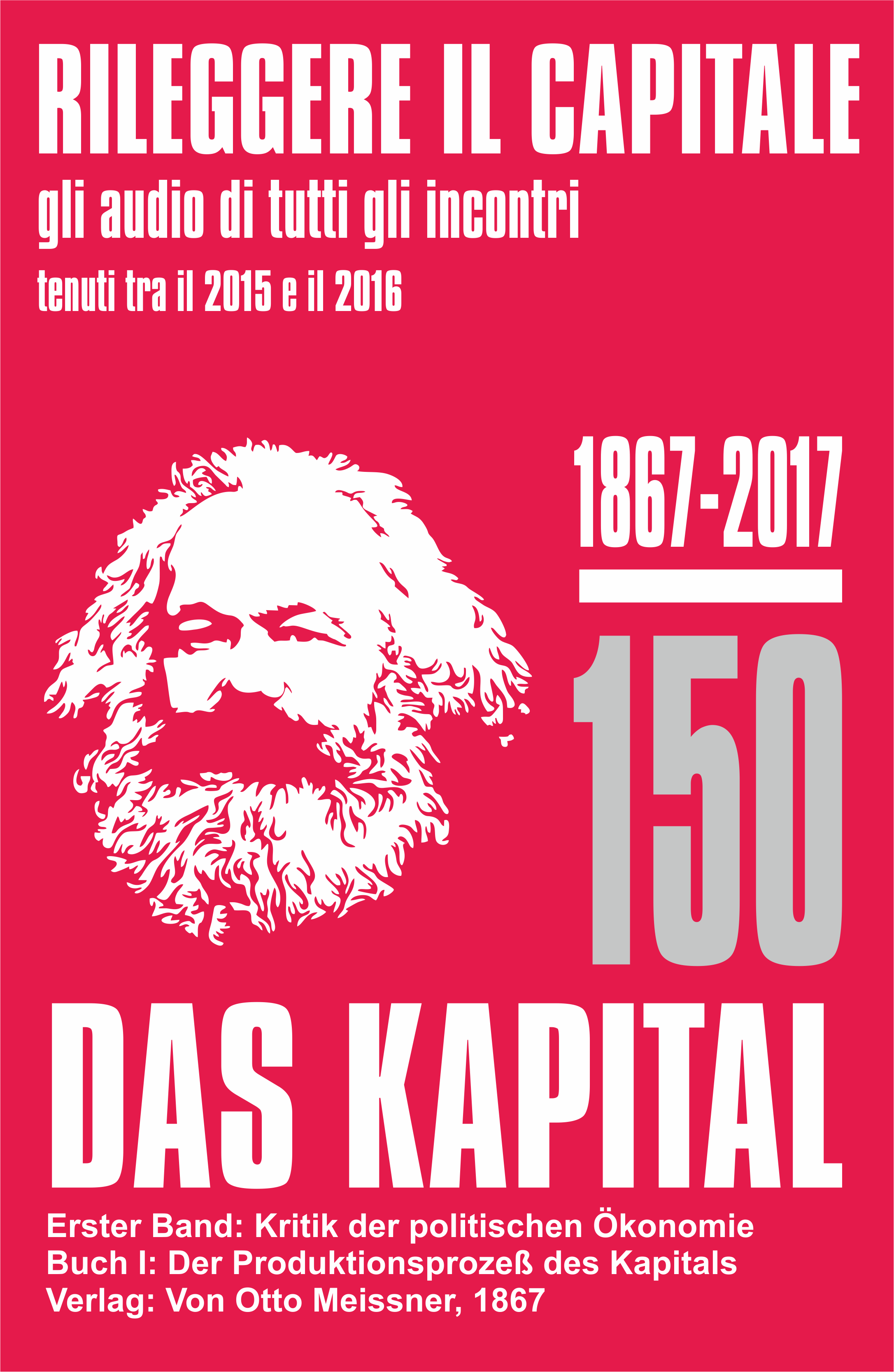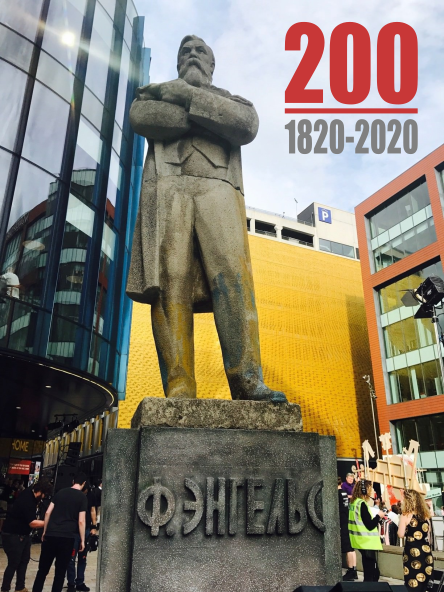Cesare Bermani | La volante rossa. Introduzione
Prima parte di un articolo dello storico Cesare Bermani pubblicato dalla rivista Primo maggio | Laboratorio Marxista, Introduzione a Cesare Bermani, Volante rossa.

Il periodo che va dal marzo 1943 al 14 luglio 1948 si caratterizza per una “intensa attività politica delle masse, che occupano impetuosamente la scena e si radicalizzano, e il deteriorarsi dell’apparato di repressione e di controllo dello Stato” [2].
Già prima della Liberazione, al Secondo Consiglio Nazionale del Partito Comunista Italiano del 7 aprile 1945, Togliatti ha denunciato come tendenza più pericolosa tra quelle che affiorano nei diversi partiti e nei gruppi dirigenti “quella che mira ad una accentuazione progressiva delle lotte politiche e di classe, di partiti e gruppi sociali, in modo che serva a suscitare complicazioni e disordini, a far sorgere situazioni corrispondenti a quella che esistette nel 1919-’20 e che anche allora fu per gran parte provocata ad arte dai reazionari. In occasione della liberazione del Nord, questa tendenza vorrebbe imporre all’Italia quella che chiamerei una prospettiva greca, cioè la prospettiva di un urto violento, di un conflitto armato tra le forze organizzate del fronte antifascista e forze della polizia e dell’Esercito dirette da elementi anti-democratici. Lo scopo che si propone questa tendenza […] è di evitare una consultazione popolare a più o meno breve scadenza, provocare indefinitamente l’occupazione d’Italia da parte degli eserciti liberatori alleati, e quindi porre una barriera quasi insuperabile all’avanzata delle forze democratiche, e ritornare ad un regime se non apertamente fascista, almeno di tipo fascista. Lavorano per questa tendenza alcuni determinati gruppi cosiddetti ‘estremisti’ provocatori, nelle cui file non escludiamo si possano trovare alle volte onesti lavoratori e onesti democratici che non comprendono la situazione del paese, ma la cui direzione è senza dubbio in mano di persone che agiscono per portare l’Italia un’altra volta a rompersi l’osso del collo. […] Non troviamo nulla di strano nel fatto che quando indaghiamo l’attività di questi gruppi troviamo quasi sempre fili che ci portano molto lontano e molto in alto. A una estremità vi è il trotskista, che parla nel modo che si ritiene più opportuno per ingannare i lavoratori, e dall’altra il ‘generale’ reazionario forse qualchedun altro ancora, che lavora consapevolmente per raggiungere un determinato obbiettivo” [3].
Se è quindi escluso che il gruppo dirigente del PCI “si proponesse di innestare nella guerra di liberazione la lotta rivoluzionaria per il socialismo” [4] tuttavia il fatto che i partiti della sinistra abbiano guidato e organizzato la lotta armata fa sì che permanga a lungo “in rilevanti settori delle masse da essi influenzate la sensazione di volersi continuare a porre il problema della conquista rivoluzionaria del potere” [5]. D’altra parte lo stesso PCI è alla Liberazione “la sintesi di un vasto e confuso movimento di massa a carattere rivoluzionario, di quadri e di militanti di limitata preparazione politica e di grande capacità organizzativa” [6], per cui anche sue avanguardie interne – particolarmente numerose e formatesi nel corso della lotta armata – sono permeate da questa tensione rivoluzionaria e considerano quindi la volontà dei dirigenti del partito di evitare scontri frontali di classe e di ampliare le loro alleanze politiche come una temporanea battuta d’arresto tattica, in attesa che una congiuntura internazionale propizia possa consentire la conquista rivoluzionaria del potere.
I partigiani garibaldini alla Liberazione non hanno disarmato: hanno per lo più consegnato agli Alleati dei ferrivecchi, i faciloni modello 91, ma mitra e Panzerfaust sono finiti ben oliati in depositi clandestini. Si è trattato di una operazione caotica, largamente spontanea, che ha coivolto migliaia e migliaia di compagni, che divengono poi di fatto i gestori di queste armi [7].
Nel PCI non esiste una vera e propria alternativa organizzata alla linea di Salerno, ma tuttavia vi è in esso un marcato atteggiamento di preoccupazione per quanto può accadere in quell’Europa del dopoguerra, preoccupazione che sale dalla base e si esprime poi nell’apparato e persino in Direzione.
Sono anni in cui l’autonomia della classe si fa sentire all’interno dello stesso PCI, che ha allora più le caratteristiche di un movimento che non quelle di un partito strutturato in modelli organizzativi rigidi. Sicché – come ha ricordato recentemente Giorgio Amendola – «la linea del centro del partito veniva accettata, ma con grandi riserve, con quella “doppiezza”[…] chenon era atteggiamento di Togliatti o di pochi dirigenti, ma posizione largamente diffusa nella base e nei quadri del partito. Sì, bisognava utilizzare le possibilità legali, conquistare comuni e seggi in Parlamento, ma per occupare posizioni che sarebbero servite quando l’ora X sarebbe finalmente scoccata.[…]. La conservazione di depositi di armi, gli atti di violenza effettuati come strascichi della guerra partigiana, i diffusi atteggiamenti di intimidazione (Verrà il momento! Vi faremo pagare !) non furono tutte invenzioni della propaganda democristiana […]. La direzione del PCI, sotto la guida di Togliatti, fece molto per correggere i comportamenti settari di una parte del partito. Bisogna ancora accertare fino a quale punto la linea di Togliatti fosse condivisa realmente da tutti i membri della Direzione […].
In verità tutto il PCI non era ancora convinto dell’utilità e della possibilità di condurre un’azione coerente per la trasformazione della società nel quadro di una Costituzione di cui si andavano fissando i caratteri» [8].
E’ in questa situazione che si sviluppano fenomeni come quello della Volante Rossa. Infatti nel corso del 1945, vicino o all’interno del PCI, si formano anche dei gruppi paramilitari, e di alcuni di essi «se ne parla ad esempio, al momento del II Congresso provinciale di Torino (1-2-3 novembre ’45) come di “iniziative e adesioni estremiste per costituzioni di squadre armate, GRPI-ARPI”» [9].
Note
[2] G.Galli, Storia del Partito Comunista Italiano, Milano, 1958, p.295
[3] P. Togliatti. Il PCI nella lotta contro il fascismo e la democrazia, Discorso pronunciato al 2° Consiglio Nazionale del Partito Comunista Italiani (Roma, 7 aprile 1945). In Politica Comunista (Discorsi dall’aprile 1944 all’agosto 1945), Roma, 1945, p.248 e segg.
[4] U. Terracini, La Costituzione italiana, la democrazia e il socialismo in trenta anni di vita e di lotte del PCI, “Quaderni di Rinascita” 2, Roma, 1951, p.215
[5] G.Galli, I partiti politici in Italia 1861-1973, Torino, 1975, p.306
[6] G.Galli, Storia del Partito Comunista Italiano, cit, p.261
[7] Secondo Giorgio Galli nelle settimane successive all’insurrezione ci sarebbero stati almeno 50.000 azionisti, 70.000 socialisti e 250.000-300.000 comunisti armati (vediI partiti politici, cit, pag. 310). La consegna delle armi non fu comunque un proforma. Nella sola Lombardia vennero consegnate tra maggio e giugno 102.652 fucili e moschetti, 1847 fucili automatici, 2310 mitragliatori, 1388 mitragliatrici, 184 mitragliere, 1635 pistole, 354 cannoni e mortai, 31.261 bombe a mano (L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, Firenze, 1947, p.353).
[8] G. Amendola, De Gasperi e la lotta politica nel trentennio repubblicano, in «Rinascita», Roma.n. 34, 2 settembre 1977, p. 9
[9] D. Montaldi, Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970), Piacenza, 1976, p.261